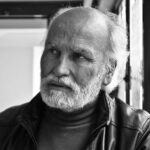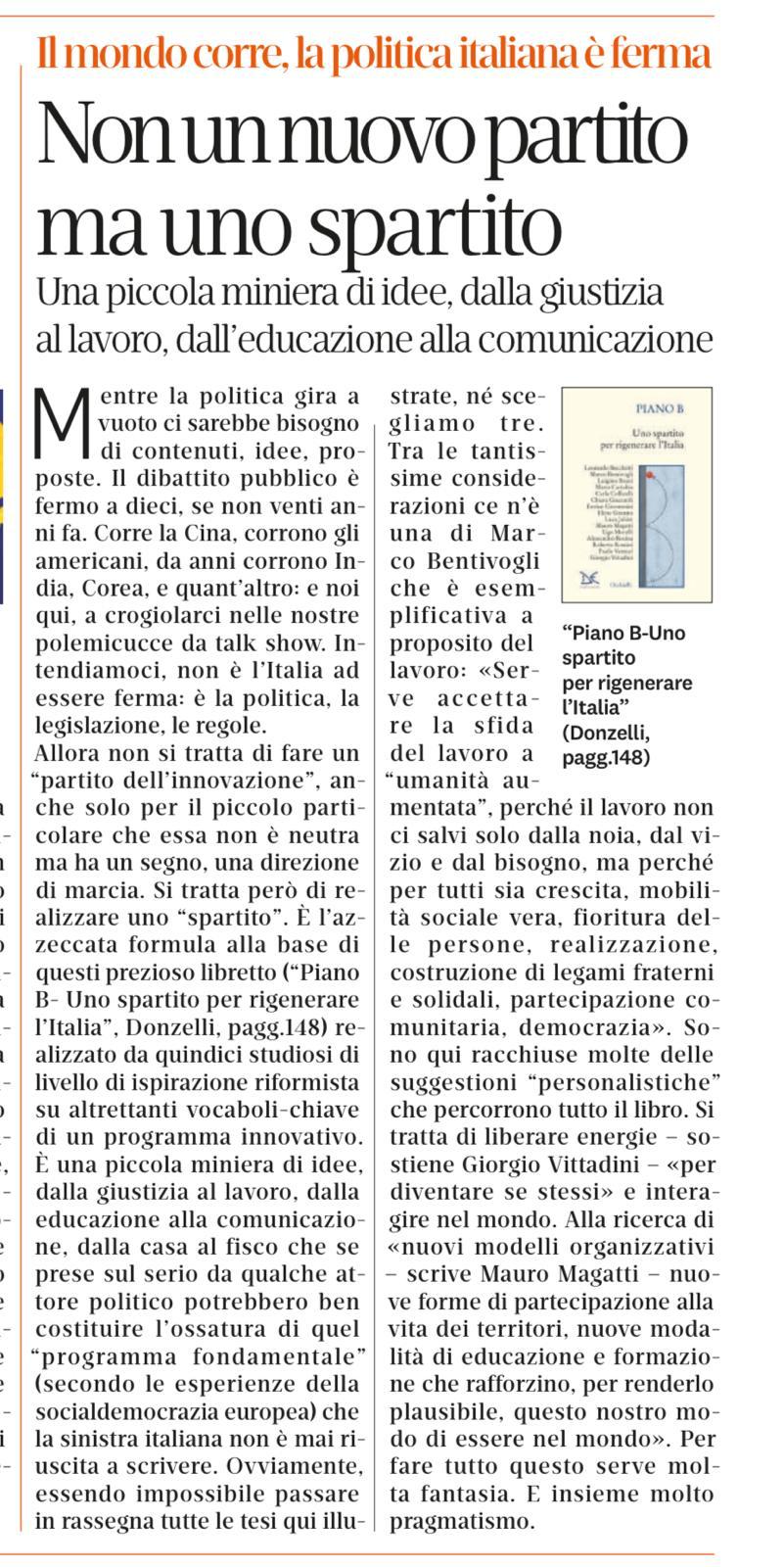A parole, tutti concordano sulla centralità della persona. Ma, al di là delle retoriche, non c’è accordo sul significato di persona.
Il discrimine che fa la differenza è il seguente: mentre l’io individuale è una monade, che si autocostituisce indipendentemente dal contesto, la persona è costitutivamente in relazione con il contesto, il resto dell’umanità e tutte le forme di vita, e perciò aperta all’altro e all’infinito.
Con la sua unicità, la persona è comprensibile solo in rapporto ai contesti in cui vive e opera, ma al tempo stesso questo rapporto non va visto in senso deterministico, in quanto la persona è tale anche e proprio perché è irriducibile al contesto e capace di trasformazione e di cambiamento. In fondo, è proprio per il mancato riconoscimento di questo paradosso tra legame e libertà che la nostra cultura si impoverisce e decade.
La persona esiste solo in rapporto al luogo in cui vive, cioè all’ambiente naturale e urbano nel quale si colloca, all’insieme delle relazioni primarie e libere quali la famiglia, il mondo associativo, la rete amicale, il vicinato; in rapporto alle istituzioni, che fanno riferimento allo Stato nazionale ma sempre più anche a dimensioni sia locali (come la scuola) sia sovranazionali oltre che alla infrastruttura tecnica, culturale e scientifica; e in rapporto all’impresa, cioè a quella forma sociale, tipica della modernità, che – combinando l’intraprendenza con l’organizzazione – costruisce l’ossatura fondamentale della vita economica, lavorativa e per molti aspetti anche sociale di una società avanzata, oltre che un luogo fondamentale di elaborazione e trasmissione di esperienze e conoscenze.
Parlare di centralità della persona vuol dire dunque considerare tutte queste dimensioni, che sono costitutive della persona stessa, nel loro intreccio. Perché è dal modo in cui concretamente queste dimensioni sono realizzate, nella loro interrelazione, che dipende la concreta possibilità che ogni singola persona, nella sua originalità, possa davvero contribuire a costruire e trasformare la realtà. Una realtà che non va vista come qualcosa di statico o immobile, ma come un processo in perenne trasformazione. E ciò è ancora più vero in un momento come quello che stiamo vivendo, di così grande e profonda trasformazione.
Mettere al centro la persona significa prendersene cura dalla nascita alla morte, investendo sulla sua educazione e formazione – che durano tutta la vita -. Significa preoccuparsi dei luoghi di vita e del lavoro e promuovere la vita associativa. Significa adoperarsi per la rigenerazione dei territori e delle forme democratiche dello Stato, oggi così minacciosamente messe in discussione.
Sarà solo prendendosi cura dai luoghi e dalle relazioni in cui le persone vivono, amano, agiscono che sarà possibile trovare la via del futuro che cerchiamo. Dentro un cammino comune in cui l’azione di ciascuno si svolge in un apprendimento continuo, ogni giorno e un po’ per volta, a mettersi in relazione a quella di tutti gli altri ed al resto.
Queste considerazioni fondative su felicità, sostenibilità, relazioni generative, intelligenza, intelletto, spirito e persona non potranno incarnarsi e declinarsi nella realtà di oggi se non contribuiranno a plasmare un nuovo paradigma sociale ed economico (una nuova economia sociale e civile) che superi le visioni anguste di persona, ambiente, impresa, valore e azione politica, per aprirle a queste dimensioni più fondanti e costitutive.
Nel vecchio modello la persona era homo economicus, miopemente autointeresssato, vittima della trappola della sfiducia. Nel nuovo modello la persona è piuttosto un cercatore di senso che ha la potenzialità di diventare maestro di relazioni e di realizzare attraverso meccanismi di fiducia e meritevolezza di fiducia, che chiamiamo capitale sociale, la quinta operazione, quella della cooperazione dove uno “con” uno fa sempre più di due, perché mette in squadra e a fattor comune una molteplicità e una ricchezza di esperienze e competenze eterogenee e non sovrapponibili.
L’impresa allora non è più massimizzatrice di profitto “non importa come” (senza alcuna considerazione per i legami e le interdipendenze della propria azione in termini di effetti sociali ed ambientali) ma diventa socialmente responsabile, ricca di senso e nasce una nuova “biodiversità organizzativa” promossa da una generazione di imprenditori più ambiziosi, che non guardano solo al profitto ma anche all’impatto sociale ed ambientale.
Gli indicatori di benessere, fondamentali per indicare la direzione di marcia delle società, non considerano la crescita economica condizione sufficiente per la felicità e il benessere ma usano un insieme di dimensioni (salute, istruzione, qualità della vita di relazioni…) centrali per il ben vivere e mettono al centro il tema della generatività declinandolo in indicatori specifici. La politica sociale ed economica non è decisa dall’alto da un sovrano illuminato che corregge i limiti dei meccanismi di mercato.
Alle due mani tradizionali (mercato ed istituzioni) si uniscono la terza – delle imprese ed organizzazioni sociali responsabili – e la quarta – della cittadinanza attiva -. Le istituzioni riconoscono in questo nuovo modello che il loro ruolo migliore è nell’essere levatrici delle energie della società civile.
Il sistema a quattro mani è infinitamente più generativo e ricco di senso di quello a due mani e promuove concretamente il principio della sussidiarietà (meglio che un problema sia risolto dalla comunità vicina ad esso che da un’istituzione centrale e distante) alimentando la crescita e la vitalità della società civile che è la vera forza della democrazia.
Occorre rendersi conto che la sfida della cittadinanza attiva e generativa e quella del modello a quattro mani di cui abbiamo detto, si giocano principalmente nella ricerca di risposte concrete ai tanti problemi che il momento storico attuale ci presenta – sociali, ambientali, politici ed economici – , e che gli sforzi di chi è già impegnato nelle diverse forme di impegno civico e di attivismo sociale devono essere rivolti in via prioritaria alla individuazione di un linguaggio e di un terreno di azione comuni, su cui fare massa critica.
In questo senso riteniamo che azioni concrete come le battaglie per la sostenibilità planetaria e la sfida climatica (attraverso le comunità energetiche e le fonti rinnovabili), per il consumo responsabile (attraverso il voto con il portafoglio), per la lotta alle diseguaglianze ed alle vecchie e nuove povertà, per la promozione della dignità del lavoro, della cultura, del rispetto delle diversità e della cooperazione e coprogettazione a tutti i livelli, e per la amministrazione condivisa siano da porre in primo piano.